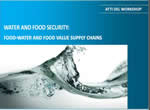All’interno della nuova PAC 2014 ci sono fondi per l’Italia pari a 20.8 miliardi di Euro, di cui 18.6 destinati all’attuazione dei programmi regionali e 2.2 a programmi nazionali. I programmi nazionali, coordinati con un Programma Operativo Nazionale (PON), si muoveranno seguendo quattro linee di intervento:
· gestione del rischio (1.6 miliardi di euro);
· infrastrutture irrigue (300 milioni di euro);
· biodiversità animale (200 milioni di euro);
· rete rurale nazionale (100 milioni di euro).
La gestione del rischio verrà affrontata in un convegno che si terrà a fine gennaio ad Assisi dal titolo “Futuro della gestione del rischio in agricoltura tra cambiamenti climatici a nuova PAC” e organizzato dal Ce.S.A.R. (Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale).
Il piano irriguo nazionale sta assumendo una notevole rilevanza a seguito dei frequenti eccessi di pioggia o scarsità di acqua che stanno colpendo ripetutamente l’agricoltura italiana. La misura prevede interventi connessi alle strutture irrigue e non alla bonifica ambientale in senso lato, in quanto tali interventi non possono essere posti carico del settore agricolo. Confagricoltura è intervenuta sul tema in quanto l'irrigazione e la qualità del servizio irriguo costituiscono fattori di sviluppo fondamentali per le imprese.
Secondo Confagricoltura è necessario rendere più moderne le reti di adduzione e distribuzione, ristrutturandole per ridurre le perdite di distribuzione, razionalizzare e ridurre i consumi. Inoltre il Presidente di Confagricoltura ritiene opportuno incentivare quanto più possibile la creazione di bacini artificiali aziendali, non sufficientemente presenti. Ciò permetterà, qualora ce ne fosse il bisogno, di effettuare irrigazioni di soccorso nei periodi siccitosi, utilizzando acque accumulate nelle stagioni piovose. Infine, serve una gestione sostenibile e integrata del suolo, promuovendo opportune pratiche conservative nonché attuando un piano di protezione e di difesa dell'assetto idrogeologico.
All’interno del capitolo della biodiversità animale, verranno finanziate le attività nazionali e regionali relative al miglioramento della biodiversità animale (informazioni, banche dati, controlli utili alla selezione). La riorganizzazione del sistema allevatoriale deve rispettare il principio di separazione fra le attività di miglioramento della biodiversità, poste a carico nazionale, da quelle di consulenza da attivare a livello regionale.
Per conoscere e capire meglio la PAC e le opportunità che essa offre, AGRIREGIONIEUROPA ha attivato un corso gratuito di E-Learning proprio sulla PAC 2014-2020. Il corso è suddiviso in sette moduli contenenti brevi lezioni di circa 5-10 minuti l'una. Esso è rivolto a tutti coloro che si interessano a vario titolo di agricoltura e di sviluppo rurale e che hanno una preparazione universitaria di base.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 dicembre 2013 sono state introdotte modalità semplificate di accesso al Fondo di Garanzia per le imprenditrici e le società a prevalente partecipazione femminile. Le imprese che accedono a questo strumento hanno la possibilità di presentarsi a banche o a confidi con la garanzia dello Stato. Lo Stato, infatti, si assume una parte del rischio del prestito che l'intermediario concede, facilitando così il finanziamento delle PMI femminili. Le risorse della Sezione Speciale, pari a 20 milioni di euro, sono impiegate per interventi di garanzia diretta, controgaranzia e cogaranzia del Fondo mediante compartecipazione alla copertura del rischio. Il 50% della quota è riservata alle nuove imprese o "start up". Informazioni dettagliate sul Fondo sono reperibili sul sito della “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità".
Per saperne di più:
Corso e-learning sulla PAC
Confagricoltura
Agricoltura24
Ce.S.A.R. (Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale)
Fondo di Garanzia