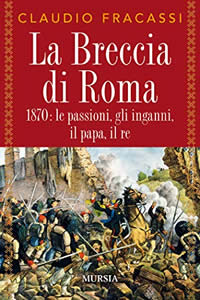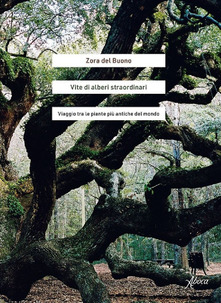Il Sapiens è l’unica specie che passando attraverso fasi evolutive e di adattamento migliora di molto la qualità della vita. Passa da cacciatore/raccoglitore ad agricoltore sfruttando proprio la selezione naturale che i vegetali adottano fin dalla loro comparsa sulla Terra. E i nostri antenati hanno addomesticato, attraverso le pratiche agricole, le piante più produttive e resistenti applicando una prima inconsapevole selezione genetica, oltre a praticare la prima rivoluzione tecnologica che è proprio l’agricoltura.
Le dieci lezioni di Michele Morgante, introdotte da domande e considerazioni di Caterina Visco, conduce il lettore in un percorso di conoscenza sulle tecnologie della discordia, così come le definisce l’autore stesso: dall’ibridazione alla transgenesi passando per la mutagenesi indotta arrivando all’editing genetico, con linguaggio scientifico molto puntuale, tuttavia chiaro e divulgativo anche grazie al glossario finale.
La necessità di conciliare la quantità della produzione agricola con la qualità e salubrità è una delle argomentazioni principali affrontate. Il mais, per fare l’esempio più eclatante, arriva nel nostro mondo dopo la scoperta dell’America, ma già i Maya lo utilizzavano come alimento e naturalmente avevano sperimentato la selezione a partire dal selvatico teosinte, poco utile alla nutrizione umana. La selezione delle piante migliori è comunque basata sulla genetica e questo è avvenuto anche nella Mezzaluna Fertile a partire dalle graminacee selvatiche per arrivare a piante con semi più adeguati alla nutrizione umana. Ora che la popolazione umana ammonta a 7 milardi e mezzo di individui, con esigenze sempre maggiori di alimenti proteici, diventa necessario l’aumento della produzione, ad esempio del mais, utilizzato come alimento per i bovini.
L’ibridazione permette l’individuazione di sementi che aumentano la produzione, la resistenza alle malattie e al cambiamento delle condizioni climatiche. Ma l’utilizzo dei semi ibridi pone la questione della proprietà del seme da riproduzione. In passato, la proprietà del seme da coltivare era dell’agricoltore che teneva i semi migliori per la semina dell’anno successivo. Gli ibridi sono sterili e attualmente l’agricoltore deve approvvigionarsi di sementi dalle multinazionali che le producono.
La selezione e ibridazione sono quindi pratiche di miglioramento genetico e precedono le biotecnologie che intervengono direttamente nel patrimono genetico a livello di DNA. All’inizio degli anni settanta avvengono le prime pratiche di clonaggio in campo farmaceutico per la produzione ad esempio di insulina o del fattore di crescita. Di fronte a questi risultati importanti per la salute umana, l’opinione pubblica non ha manifestato ostilità esplicite. A partire dal decennio successivo inizia la sperimentazione sulle piante attraverso le biotecnologie che portano a organismmi geneticamente modificati in base a precisi obiettivi come la resistenza a specifici diserbanti o a parassiti. La diffusione di prodotti agricoli OGM per l’alimentazione umana e animale accende da subito un acceso dibattito nell’opinione pubblica e anche nel mondo scientifico e in assenza di evidenze certe di sicurezza, la maggior parte dei governi adotta il principio di precauzione. Resta comunque la necessità di soddisfare il bisogno primario dell’umanità: alimentarsi. Le tecnologie della discordia, come vengono definite nel sottotitolo dall’autore, se applicate in modo corretto e con adeguate precauzioni, sono attualmente l’unica strada per fornire di cibo il pianeta. Al consumatore che chiede prodotti legati alla tradizione o provenienti da agricoltura biologica viene collegato il concetto di giustizia sociale: se davvero questi alimenti sono migliori sono anche molto più costosi e accessibili solo a una limitata pecentuale di consumatori.
Il lettore coglie anche un altro importante messaggio: nel futuro è necessaria la diminuzione del consumo di proteine di origine animale. Sarà un processo lento ma necessario se si parte dai dati numerici sul costo a livello ambientale della produzione della carne. A questo va legata l’importanza di tracciare l’alimento aggiungendo alle informazioni nutrizionali anche l’etichetta di sostenibilità dello stesso, indicando proprio il costo in termini ambientali della produzione, ad esempio di una bistecca o di una spigola di allevamento.
Questo testo permette da un lato una conoscenza dettagliata delle diverse biotecnologie anche in fase di sperimentazione, dall’altro rivolge un messaggio a ciascuno di noi: cambiare i comportamenti individuali a livello alimentare e sull’uso delle risorse naturali diventa un imperativo.
A commento del testo possiamo affermare che l’adattamento all’ambiente dei vegetali, le strategie per procurarsi il cibo degli animali sono delle tecnologie in senso stretto: azioni che permettono di raggiungere un risultato. La samara dell’olmo, i pappi del soffione sono programmati per volare e atterrare lontano dalla pianta madre per colonizzare superfici adatte a germinare. La ragnatela tessuta dal ragno, la lingua della rana che permette la cattura delle piccole prede o le zampe del geco sono esempi nel mondo animale. Strategie che permettono la sopravvivenza e la riproduzione trasmesse direttamente dal patrimonio genetico. Ma il Sapiens fa qualcosa in più, se è sempre meglio, lo vedremo.
Alberta Vittadello