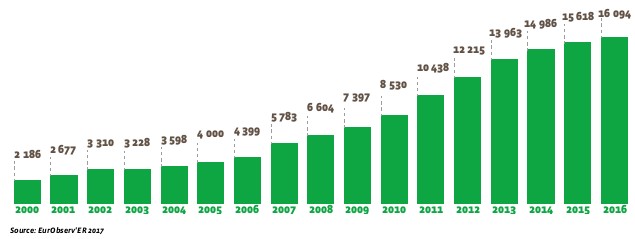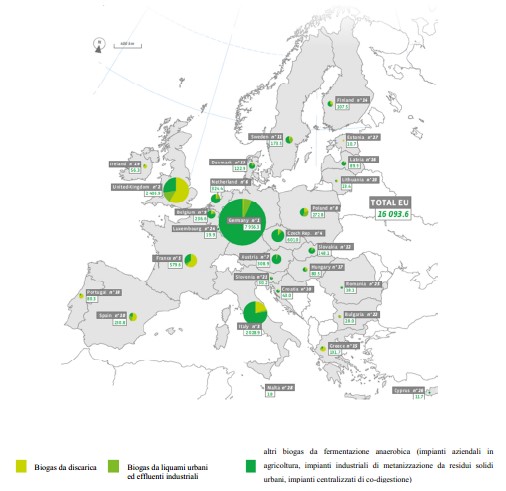La sostenibilità delle città tema chiave dell’Agenda internazionale
Nonostante occupino solamente il 3 per cento della superficie terrestre, le città consumano l’80 per cento delle risorse naturali e producono il 70 per cento delle emissioni di CO2 a livello globale. Secondo stime del think tank internazionale Brookings Institution, le prime 300 aree metropolitane del pianeta generano quasi la metà dell’output economico globale, sebbene ospitino appena il 20 per cento della popolazione mondiale. Milano punta sulla sostenibilità ambientale e si pone come città-modello a livello europeo.
Il ruolo delle città nell’Agenda internazionale
Le grandi città del mondo hanno ormai assunto un ruolo di primo piano sotto il profilo socio-economico, ambientale ed energetico. Attualmente, a livello globale, il 55 per cento dei 7,5 miliardi di persone che abitano il pianeta risiede nelle aree urbane e il numero è destinato a salire al 70 per cento entro il 2050, quando la popolazione mondiale avrà raggiunto, stando alle stime, 9,7 miliardi di persone. Nonostante occupino solamente il 3 per cento della superficie terrestre, le città consumano l’80 per cento delle risorse naturali e producono il 70 per cento delle emissioni di CO2 a livello globale. Secondo l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, nei prossimi anni, le città giocheranno un ruolo fondamentale per il benessere e la sicurezza dei cittadini, ma presenteranno anche problemi di ordine economico, sociale ed ambientale. A questo proposito, conviene sottolineare che il Goal 11 dell’Agenda 2030 dichiara che la comunità internazionale ha il compito di “rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” entro il 2030. L’obiettivo fissato dalle Nazioni Unite richiede l’adozione di politiche incentrate sulla sostenibilità ambientale ed energetica delle città e sullo sviluppo inclusivo in termini di riduzione delle disuguaglianze sociali (Goal 10), di rispetto della dignità del lavoro (Goal 8), di azzeramento della povertà (Goal 1) e della fame (Goal 2), di garanzia di un’istruzione di qualità per tutti i cittadini (Goal 4). Secondo il think tank internazionale Brookings Institution, le prime 300 aree metropolitane del pianeta generano quasi la metà dell’output economico globale, sebbene ospitino appena il 20 per cento della popolazione mondiale. Perciò si capisce il ruolo fondamentale giocato dalle città. Tokyo, ad esempio, ha un output economico paragonabile a quello della Corea del Sud, ovvero la quindicesima economia al mondo. New York rappresenta un’economia che per dimensioni raggiunge quella del Canada e lo stesso avviene per Los Angeles rispetto all’Australia e per Londra rispetto ai Paesi Bassi. In altri termini, le grandi città del mondo rappresentano i centri fondamentali dell’economia globale e la loro importanza è destinata a crescere nei prossimi anni. Se negli anni delle società industriali la percentuale dei lavoratori operai arrivava anche al 90 per cento del totale, nelle società di oggi, caratterizzate sempre di più dalla produzione di beni immateriali e da economie dell’informazione basate sulle tecnologie digitali, l’occupazione intellettuale ed impiegatizia supera quella operaia, ormai ridotta alla metà della popolazione complessiva. Le conseguenze dell’urbanizzazione e della forte concentrazione economica nelle città si riflettono tuttavia negativamente sulla vita dei cittadini poveri o con redditi bassi che, a differenza delle classi più agiate, che vivono nei quartieri migliori e che usufruiscono di una moltitudine di servizi, si trovano costretti a vivere in aree urbane e sobborghi caratterizzati da infrastrutture ed edifici degradati e servizi limitati.
Il programma lanciato dall’Unione europea
Per far fronte a queste problematiche, l’Unione europea, a partire dal 2016, ha elaborato un dossier relativo a 10 mila centri urbani sparsi per il mondo, che sarà presentato alle Nazioni Unite a marzo del prossimo anno. Il dossier, realizzato insieme con la FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura), l’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e la Bancamondiale, mira a realizzare un programma condiviso di cooperazione internazionale urbana tra le principali città del mondo. Attualmente, il programma vede la partecipazione di 70 città del mondo, 35 delle quali si trovano nei paesi dell’Ue, le cui amministrazioni stanno lavorando a piani d’azione locali dedicati alla qualità dell’ambiente urbano, dell’accesso alla risorse idriche, dei trasporti e della salute dei cittadini che vivono nelle città. Tra le città che partecipano al programma ci sono Oslo, che di recente ha annunciato di voler diventare la prima città senza auto entro il 2019, Parigi, che negli ultimi anni ha realizzato numerose zone pedonali e parchi all’interno della città, tra i quali anche la nota “Promenade plantée” (Figura 1). Nel programma sono coinvolte inoltre Chicago e New York, dove nel 2011 è stata inaugurata la High Line, una ferrovia sopraelevata dismessa trasformata in passeggiata verde e luogo di svago. Nelle città si stanno poi diffondendo varie forme di bike sharing, spesso senza stazioni di riconsegna, non soltanto in Europa, ma anche in Cina, dove il trasporto su bicicletta in città è passato negli ultimi due anni dal 5,5 all’11,6 per cento del totale, con notevoli benefici in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico e di miglioramento della qualità di vita dei cittadini. Londra ha recentemente approvato una serie di progetti urbani tra i quali il “100 Pocket Parks”, che prevede la realizzazione di cento nuovi parchi in 26 quartieri della città, e il “National Park City”, che mira a ricoprire la capitale londinese di infrastrutture verdi (Green Roof and Walls).

Figura 1. Scorcio della Promenade plantée, a Parigi (foto: Andrea Campiotti)
Milano punta sulla sostenibilità ambientale
Quando si parla di progetti improntati alla sostenibilità ambientale delle città, non si può non citare Milano che con il suo Bosco Verticale (Figura 3), realizzato nel 2014, ha fatto parlare di sé in tutto il mondo, ponendosi come modello di densificazione della natura all’interno della città. A Milano sono in corso numerosi programmi di inverdimento di balconi, terrazzi e pareti degli edifici, sia pubblici che privati. In questo modo, la città ha avviato una rapida riconversione degli edifici urbani all’insegna della sostenibilità, diminuendo le “isole di calore” (heat island), tutelando la biodiversità vegetale e animale, diminuendo l’inquinamento atmosferico e migliorando la qualità di vita dei cittadini
Figura 2. Bosco Verticale a Milano (foto: Andrea Campiotti)
Fonti per approfondire:
- Il ritorno delle città stato. Aspenia, 2018.
- Javier Echeverria, Telepolis. La nuova città telematica. Laterza, 1994.
- Urban Agenda for the EU. ec.europa.eu .
Nota:
L’immagine d’intestazione dell’articolo mostra una parte dello skyline di Milano. La foto è stata scattata da Andrea Campiotti (autore dell’articolo).