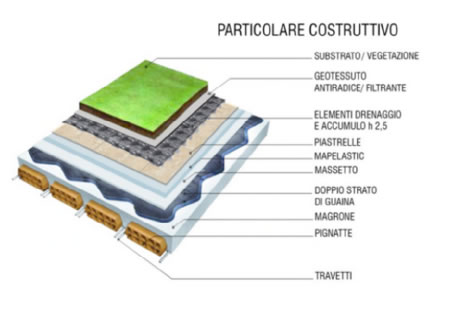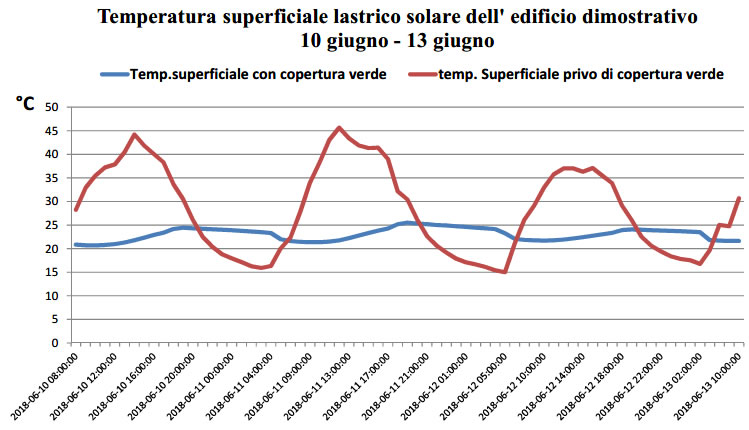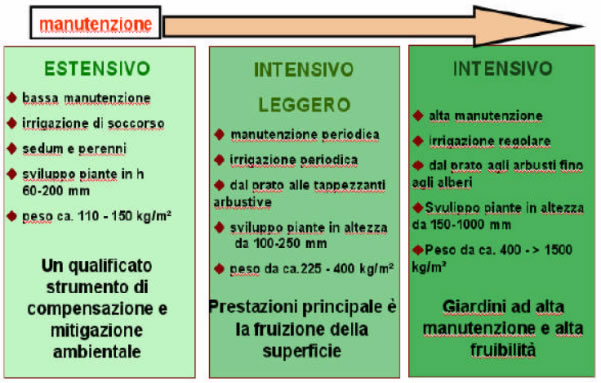Il Parlamento europeo dichiara guerra alle plastiche monouso
Il Parlamento europeo approva una nuova normativa sul consumo di plastica monouso che punta a vietare, a partire dal 2021, la vendita di posate, bastoncini cotonati, piatti, cannucce, miscelatori per bevande e bastoncini per palloncini. Al bando anche scatole usa e getta per panini, contenitori alimentari per frutta, verdura, dessert, gelati e articoli di plastica oxodegradabili. Il 6 novembre cominceranno i negoziati con i Paesi dell’Ue e, se tutto dovesse procedere nei tempi stabiliti, la normativa potrebbe essere approvata definitivamente entro marzo 2019.
Dal 2021 sarà vietato vendere una serie di articoli di plastica monouso, come posate, bastoncini cotonati, piatti, cannucce, miscelatori per bevande e bastoncini per palloncini. Ieri, il Parlamento europeo ha approvato una nuova normativa che aggiunge all’elenco della materie plastiche vietate, proposto dalla Commissione europea a fine maggio con la COM(2018) 340 final , anche i sacchetti di plastica, gli articoli di plastica oxodegradabili (plastiche con l’aggiunta di additivi che ne accelerano la frammentazione in parti minuscole per effetto della radiazione solare), i contenitori in polistirolo espanso. Tra gli altri articoli di plastica che dovranno essere vietati a partire dal 2021 compaiono anche le scatole usa e getta per panini e i contenitori alimentari per frutta, verdura, dessert e gelati. I Paesi membri dell’Unione europea dovranno ridurre il consumo di questo tipo di prodotti del 25% dentro il 2025. Altri prodotti di plastica, come, ad esempio, le bottiglie per bevande, dovranno essere raccolte separatamente e riciclate al 90% sempre entro il 2025. Inoltre, la nuova normativa invita i vari Paesi membri ad elaborare piani nazionali per incoraggiare il consumo di prodotti adatti ad uso multiplo, nonché il loro riciclo e riutilizzo. Il Parlamento europeo dichiara poi guerra ai mozziconi di sigarette che contengono plastica, la cui quantità di rifiuti dovrà essere ridotta del 50% entro il 2025 e dell’80% entro il 2030. Saranno gli stessi produttori di tabacco a farsi carico dei costi di trattamento e di raccolta, compreso il trasporto. Un mozzicone di sigaretta, sottolinea il Parlamento europeo, può inquinare tra i 500 e 1.000 litri d’acqua e, se gettato in strada, può richiedere fino a 12 anni per disintegrarsi. Si tratta del secondo articolo di plastica monouso più presente tra i rifiuti. La nuova normativa impone lo stesso ai produttori di attrezzi da pesca che contengono plastica, i quali dovranno contribuire al riciclo di almeno il 15% dei prodotti entro il 2025. I Paesi dell’Ue, invece, dovranno garantire che almeno la metà di tutti gli attrezzi da pesca contenenti plastica perduti o abbandonati in mare, come reti, fili da pesca e cime, che rappresentano il 27% dei rifiuti che si trovano nelle spiagge europee, venga raccolta ogni anno. I prodotti elencati nella nuova normativa, fa sapere il Parlamento europeo, rappresentano il 70% di tutti i rifiuti marini e tra questi ci sono i 10 prodotti che inquinano maggiormente le spiagge europee (Figura 1).

Figura 1. I dieci rifiuti plastici più diffusi nelle spiagge europee (fonte: Parlamento europeo)
A causa della sua lenta decomposizione, la plastica si accumula nei mari, negli oceani e nelle spiagge di tutto il mondo. I suoi residui si trovano in numerose specie animali, non solo marine, e finiscono, di conseguenza, nella catena alimentare dell’uomo. L’Unione europea produce 26 milioni di tonnellate di rifiuti plastici ogni anno, di cui solo il 30% è riciclabile, e di questi finiscono nel mare tra le 150 e le 500 mila tonnellate, con significative ricadute sull’ambiente e sulle specie che abitano il mare. A questo proposito, un rapporto pubblicato dalle Nazioni Unite nel 2016 sottolineava che i rifiuti marini, composti prevalentemente da plastica, minacciano la sopravvivenza di oltre 800 specie animali che muoiono ingerendo o restando intrappolare nei rifiuti. Il problema non affligge solo grandi specie animali, come i cetacei e le tartarughe marine, ma riguarda anche altri organismi come ostriche, cozze, coralli e persino plancton, inquinando l’intera reta trofica marina. E non sono solo le specie marine ad essere colpite dalla piaga dell’inquinamento da plastica. Una ricerca pubblicata nel 2015 sulla rivista scientifica Pnas ha rilevato che il 90% di tutti gli uccelli marini del mondo ha residui di plastica nelle proprie viscere, ingeriti perché confusi per cibo. Nel 2050, se i consumi di plastica dovessero continuare al ritmo attuale, secondo la ricerca, ben il 99% degli uccelli si troverebbe ad avere plastica all’interno del proprio organismo. Per quanto riguarda il mar Mediterraneo, secondo uno studio del WWF, pubblicato lo scorso giugno, la plastica rappresenta circa il 95% di tutti i rifiuti gettati in mare e i suoi residui si trovano in oltre 130 specie marine.
Questi sono dati allarmanti che devono far riflettere le istituzioni europee, l’industria e i cittadini sulla necessità di ridurre i consumi di prodotti di plastica, in particolare di quelli monouso, e pongono l’accento sul dovere che noi tutti abbiamo di salvaguardare l’ambiente in cui viviamo. La nuova normativa, sottolinea la Commissione europea, comporterà un risparmio di 22 miliardi di euro per danni ambientali e di 6 miliardi per i consumatori. Ora, il Parlamento europeo dovrà avviare i negoziati con il Consiglio (l’organo politico dell’Unione) non appena i ministri dei Paesi dell’Ue avranno definito la propria posizione in merito alla normativa. I negoziati con il Consiglio cominceranno il 6 novembre e, se tutto dovesse procedere nei tempi stabiliti, la normativa potrebbe essere approvata definitivamente entro marzo 2019, mentre i divieti veri e propri non entreranno in vigore prima del 2021.